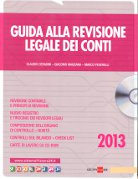I PREZZI DI TRASFERIMENTO NEI GRUPPI TRANSFRONTALIERI
ARTICOLO - Pubblicato il: 18/03/2013 - Da: G. Manzana E. Iori
Il trattamento fiscale dei prezzi di trasferimento, ossia dei prezzi praticati nell’ambito di transazioni fra società, imprese, stabili organizzazioni o in generale enti appartenenti al medesimo gruppo multinazionale, è disciplinato dall’art. 110, comma 7 del Tuir.
La norma non interferisce sui criteri di determinazione contrattuale/civilistica dei prezzi di trasferimento limitandosi a stabilire che, qualora detti prezzi siano inferiori a quelli praticati in condizioni di libera concorrenza, si richiede una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Articolo 110- Norme generali sulle valutazioni
(…)
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. (…)
La norma riguarda le operazioni svolte da imprese italiane con società estere le quali:
- controllano, direttamente o indirettamente, l'impresa italiana;
- sono controllate dall'impresa italiana;
- sono controllate dalla stessa società che ha il controllo sull'impresa italiana.
Nel caso in cui, valutando i componenti di reddito derivanti da tali operazioni al valore normale, così come definito dal comma 2 dell'art. 110,
- - dei beni ceduti e dei servizi prestati,
- - dei beni e servizi ricevuti,
si ottenga un aumento del reddito per le imprese nazionali, questi devono essere valutati a tale valore.
In pratica, quindi, al verificarsi di tale condizione, il valore normale può essere adottato nella valorizzazione di tali operazioni con forza di presunzione legale.
La finalità della norma è quella di impedire il travaso di utili dall'Italia a uno Stato estero attraverso operazioni contabilizzate ad un valore diverso da quello normale.
In base al secondo periodo del comma 7 le disposizioni in argomento si applicano anche nel caso in cui dall'applicazione del valore normale risulti una diminuzione di reddito solo però nel caso in cui l'intervento dell'Amministrazione finanziaria sia previsto da accordi con le autorità competenti degli stati esteri nell'ambito delle speciali procedure amichevoli contro le doppie imposizioni.
La normativa nazionale in materia di prezzi di trasferimento prevede in sostanza che il prezzo dell'operazione infragruppo oggetto di verifica ("operazione in verifica") sia confrontato con il valore normale di una distinta operazione ("operazione campione") e che, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa residente, il primo sia sostituito con il secondo:
- sempre: quando da tale sostituzione deriva un incremento di tale reddito;
- soltanto qualora siano stati stipulati accordi con l'autorità competente del Paese estero: quando da tale sostituzione deriva una diminuzione del reddito dell'impresa residente.
Sul piano oggettivo, la disciplina si applica a tutte le transazioni che presentano una rilevanza reddituale e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, alle operazioni (quali cessioni e locazioni anche finanziarie) che hanno per oggetto beni materiali (beni - merce o beni strumentali) o beni immateriali (quali brevetti, marchi, know how, ecc.), alle operazioni di finanziamento ed alle prestazioni di servizi infragruppo (ad esempio per ricerca e sviluppo, servizi di tesoreria, marketing, pubblicità e così via).
In ordine ai presupposti soggettivi della disciplina in rassegna, nella nozione di "società non residente" devono farsi rientrare anche forme giuridiche non espressamente previste nel nostro sistema, ma riconosciute come società nello Stato estero.
Relativamente, poi, al concetto di "impresa residente", sottoposta al regime fiscale in parola, deve essere considerando tale chiunque eserciti professionalmente, in forma individuale o collettiva, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Pertanto, la disciplina sul transfer pricing sarà applicabile anche ai rapporti tra le stabili organizzazioni in Italia di enti non residenti e le stesse società straniere di cui le prime fanno parte.
Quanto al rapporto di "controllo" che deve intercorrere tra i due soggetti economici - nazionale ed estero - va tenuto conto, ai fini dell'applicazione della disciplina, che la citata norma del Tuir non richiama l'art. 2359 c.c. Secondo l’Agenzia delle entrate ciò sta a significare che il concetto di controllo non va inteso in senso restrittivo, ma abbraccia tutte le ipotesi in cui tra le due entità vi sia un legame, di natura formale o fattuale, da cui derivi il rischio che le transazioni poste in essere tra di esse non vengano valorizzate a prezzi di mercato (Cfr. Cir. Min. n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980).
In proposito, la stessa circolare contiene un’ esemplificazione casistica, nel cui ambito vale la pena di ricordare, in particolare:
- l'impossibilità di funzionamento per un'impresa senza il capitale,
- i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture),
- la presenza nelle due imprese di membri comuni del consiglio di amministrazione,
- la concessione da parte di un'impresa all'altra di ingenti finanziamenti,
- la partecipazione da parte delle due imprese a centrali comuni di approvvigionamento o vendita
- e, "in generale, tutte le ipotesi in cui un'impresa esercita potenzialmente un'influenza dominante sulle decisioni imprenditoriali dell'altra".
La concreta applicazione della normativa presuppone quindi l'identificazione del valore normale della "operazione campione".Tale valore trova la propria definizione normativa nell'art. 9, comma 3 del Tuir, ai sensi del quale "per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".La norma prosegue poi affermando che per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento "in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso". Lo stesso art. 9 del TUIR prevede poi autonome e specifiche regole per azioni, obbligazioni e quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalla società. In merito si veda quanto viene detto subito dopo trattando di determinazione del prezzo di trasferimento.
In considerazione del fatto che la tematica dei prezzi di trasferimento è intimamente connessa con il fenomeno della doppia imposizione internazionale, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito OCSE) ha codificato il principio di libera concorrenza (arm’s length principale), quale principio guida nell’ambito delle operazioni rientranti tra imprese associate residenti in due o più giurisdizioni fiscali differenti, nell’art. 9 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni. E, in virtù dell’esplicito riferimento operato dal Commentario al Modello OCSE all’art. 9, la tematica dei prezzi di trasferimento è stata ampiamente trattata dall’OCSE, soprattutto con la predisposizione, nel 1979, delle Linee Guida sul transfer pricing, le quali nel corso degli anni, hanno subìto significativi aggiornamenti, l’ultimo dei quali, particolarmente incisivo, recepito nel documento pubblicato in data 22 luglio 2010. La metodica desumibile dalle citate Linee Guida comporta l’effettuazione di analisi approfondite aventi ad oggetto una molteplicità di aspetti che debbono essere tenuti in debita considerazione, tra i quali il tipo di transazioni da esaminare, le politiche commerciali realizzate dal gruppo multinazionale, le condizioni del mercato esistenti, la contrattualistica di riferimento ed una analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali (in particolare delle immobilizzazioni immateriali) utilizzati dalle parti coinvolte nell’operazione. L’obiettivo è quello di definire nel modo più corretto possibile le caratteristiche delle operazioni in modo da poter procedere all’individuazione di operazioni comparabili per poter determinare il valore normale delle operazioni medesime da assumere a fini fiscali.
Inoltre, in ambito comunitario, in data 27 giugno 2006 il Consiglio dell’Unione Europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deliberato l’approvazione di un Codice di Condotta relativo alla ocumentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea, con l’obiettivo di incoraggiare la diffusione di una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'Unione europea. La documentazione definita nel Codice di Condotta costituisce un insieme standardizzato di informazioni che debbono essere fornite alle amministrazioni fiscali, declinata in modo generale così da poter essere opportunamente adattata dagli Stati membri in base alle normative nazionali e ai diversi contesti di riferimento.
Notevole rilievo, nell’ambito delle riflessioni sul transfer pricing, assume il tema dell’onere della prova. Si tratta di stabilire a chi spetti (tra Amministrazione finanziaria e contribuente) l’onere di fornire gli elementi di prova della conformità (o meno) dei prezzi di trasferimento alle norme di legge. Negli ultimi anni, si sono susseguite sentenze della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito che hanno contribuito a delineare la ripartizione dell’onus probandi nelle controversie sui prezzi di trasferimento.
Ex multis si richiama la sent. 13 ottobre 2006, n. 22023 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che “l’onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell’elusione grava in ogni caso sull’Amministrazione che intenda operare le conseguenti rettifiche (...). Ciò trova conferma anche in materia di transfer pricing posto che le direttive OCSE (...) nel rapporto del 1995 hanno espressamente sottolineato che, laddove la disciplina di ciascuna giurisdizione nazionale preveda che sia l’Amministrazione finanziaria ad essere gravata dell’onere di provare le proprie pretese, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, se non prima che l’Amministrazione fiscale abbia essa stessa provato prima facie il non rispetto del principio del valore normale (...). Ebbene l’Ufficio (...) avrebbe dovuto, innanzitutto, accertare se veramente la fiscalità in Italia era all’epoca superiore rispetto a quella in vigore nei Paesi di provenienza dei veicoli compravenduti. In secondo luogo, determinare il valore normale dei veicoli acquistati da F. Italia verificando, in concreto, se i corrispettivi pagati dalla stessa alle proprie consociate estere fossero effettivamente superiori a tale valore con indagine estesa alla sufficienza del margine di utile ricavato per coprire le spese di riparazione in garanzia ed analisi delle condizioni del mercato automobilistico mediante confronto dei prezzi praticati all’interno del gruppo F. con quello praticato da altre imprese concorrenti’’.
In altri termini, nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, se prima l’Amministrazione fiscale non
abbia essa stessa provato prima facie il mancato rispetto del valore normale.
Ancora a titolo di esempio, si cita la sent. n. 11226 del 16 maggio 2007 con cui la Suprema Corte è tornata ad esaminare la concreta applicazione della disciplina del transfer pricing, ribadendo ancora una volta che l’onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione dei prezzi di trasferimento grava sull’Amministrazione finanziaria che intende operare le conseguenti rettifiche al reddito del contribuente.
La determinazione dei prezzi di trasferimento
Al fine di individuare il valore normale da attribuire ai prezzi che si formano nell'ambito delle transazioni infragruppo sul piano internazionale, come si è già avuto modo di dire, assumono rilievo le Linee Guida sul transfer pricing, dell’Ocse (predisposte nel 1979 e successivamente oggetto di aggiornamenti, l’ultimo dei quali, particolarmente incisivo, recepito nel documento pubblicato in data 22 luglio 2010) e gli artt. 9 e 25 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 (prot. n. 2010/137654) che prevede il regime premiale di cui si dirà dopo, fa riferimento, per la determinazione del valore normale, ai criteri dell’Ocse.
L'Amministrazione finanziaria ha emanato le circolari n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980 e n. 12/1587 del 12 dicembre 1981, la circ. n. 53/E del 26 settembre 1999 e, da ultimo la Cir. n. 58/E del 2010. In tali circolari i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento elaborati dall’Ocse vengono riconosciuti, dall’Amministrazione finanziaria, come validi.
La metodica desumibile dalle citate Linee Guida comporta l’effettuazione di analisi approfondite aventi ad oggetto una molteplicità di aspetti che debbono essere tenuti in debita considerazione, tra i quali:
- il tipo di transazioni da esaminare,
- le politiche commerciali realizzate dal gruppo multinazionale,
- le condizioni del mercato esistenti,
- la contrattualistica di riferimento ed
- una analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali (in particolare delle immobilizzazioni immateriali) utilizzati dalle parti coinvolte nell’operazione.
L’obiettivo è quello di definire nel modo più corretto possibile le caratteristiche delle operazioni in modo da poter procedere all’individuazione di operazioni comparabili per poter determinare il valore normale delle operazioni medesime da assumere a fini fiscali.
Sul piano generale il documento OCSE afferma infatti che l'individuazione del prezzo di libera concorrenza non possa prescindere da alcune variabili, quali, in particolare:
- le caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto dell'operazione;
- le funzioni svolte dalle singole imprese considerate ed i rischi rispettivamente assunti;
- l'entità di capitale o patrimonio che è necessario investire per la produzione dei beni o servizi oggetto dell'operazione;
- le condizioni commerciali praticate, di natura sia economica sia finanziaria;
- le politiche commerciali adottate.
Ciò detto, nelle linee guida dell’Ocse sono elaborati specifici metodi, alcuni principali ed altri sussidiari.
Quelli c.d. "principali" sono, i metodi :
- del "confronto di prezzo",
- del "prezzo di rivendita" e
- del "costo maggiorato".
Il metodo del confronto del prezzo (CUP) si basa, in sostanza, nella comparazione del prezzo "in verifica" con quello praticato per transazioni comparabili.
Questo confronto può essere sia "esterno", se riguarda il prezzo di una transazione comparabile posta in essere tra imprese indipendenti, sia "interno", se relativo ad un'operazione tra l'impresa sottoposta a verifica ed un'impresa "terza", cioè esterna al gruppo di riferimento.
Nell'applicazione del metodo e, più in particolare, nell'individuazione delle transazioni comparabili, la circolare dell’Amministrazione finanziaria del 1980 precisa che occorre primariamente tener conto del "mercato rilevante", cioè del mercato del destinatario dei beni oggetto della transazione, della qualità del bene o servizio oggetto della transazione medesima e di altri fattori, quali il trasporto, l'imballaggio, la pubblicità, la commercializzazione, la garanzia, i tassi di cambio, le condizioni generali di vendita, il tempo della vendita, l'eventuale esistenza di diritti immateriali abbinati alla vendita, di vendite promozionali e di sconti sulla quantità.
In assenza delle condizioni per poter applicare il metodo del "confronto del prezzo", è prevista la possibilità di fare ricorso, tendenzialmente in via alternativa, ai due citati metodi del "prezzo di rivendita" e del "costo maggiorato".
Il metodo del prezzo di rivendita (Resale Minus) si basa sul prezzo al quale il bene o il servizio acquistato da un'impresa appartenente ad un gruppo viene rivenduto ad un'impresa indipendente.
Si presuppone, quindi, l'esistenza di due transazioni collegate, la prima tra due imprese consociate e la seconda tra la cessionaria del gruppo ed un'impresa terza.
L'elemento di partenza è quello noto del prezzo di rivendita del prodotto all'impresa esterna al gruppo, cioè il corrispettivo della seconda operazione.
Questo importo viene, poi, diminuito delle spese di distribuzione e di un ammontare pari al "profitto normale" per l'impresa cedente, da individuare tenendo presente anche la funzione ricoperta all'interno del gruppo ed il rischio insito nello specifico settore; in tal modo, si ottiene il valore da confrontare con il prezzo praticato per la prima transazione, cioè per quella tra le due società del gruppo (e, quindi, per la transazione).
In questo caso, l'aspetto maggiormente problematico dal punto di vista operativo è costituito dalla corretta individuazione del margine di utile da attribuire all'impresa che effettua la rivendita del bene.
A tal fine, possono essere presi in considerazione o il margine ricavato in cessioni a terzi indipendenti di beni similari precedentemente acquistati da imprese del pari indipendenti o, in alternativa, attraverso mirati controlli di coerenza esterna, il margine ricavato da terzi indipendenti nella rivendita comparabile di beni similari (cioè in una transazione del tutto estranea ai soggetti considerati, ma relativa al medesimo settore di business).
Attraverso il metodo del costo maggiorato (Cost Plus), il valore normale della transazione si ottiene aggiungendo al costo di produzione del bene un margine di utile lordo.
Detto margine può essere determinato dall'esame di quanto ricavato dalla medesima impresa in vendite a terzi di prodotti similari sul medesimo mercato (confronto interno), ovvero, in assenza di tali condizioni, con quello realizzato da terzi indipendenti in vendite similari (confronto esterno); il tutto, naturalmente, a condizione che vengano svolte uguali funzioni rispetto a quelle esercitate dal rivenditore nella transazione in verifica.
Nella quantificazione del costo di produzione, da considerare come base di partenza, devono essere ricompresi sia gli oneri diretti (materie prime, manodopera, ecc.), che quelli indiretti (spese industriali, spese generali, ricerca e sviluppo, oneri finanziari, spese commerciali, spese direzionali, ecc.).
In aggiunta ai tre metodi principali di cui si è finora detto, sono previsti alcuni metodi alternativi. A tali metodi si farà ricorso qualora risultassero maggiormente affidabili rispetto a quelli tradizionali (nel senso che a parità di affidabilità occorrerà fare riferimento ai metodi tradizionali – in tal senso vendi quanto viene detto dopo).
Si tratta, tra gli altri, dei metodi che si va di seguito brevemente a richiamare.
Il metodo della ripartizione dei profitti globali (c.d. profit split method), individua il prezzo di trasferimento da applicare in base alla ripartizione degli utili complessivi del gruppo del quale fanno parte le imprese considerate. Questo metodo è realisticamente percorribile nel caso in cui la controllante sia fiscalmente residente in Italia e possa, quindi, documentare adeguatamente le procedure interne adottate ai fini dell'allocazione dell'utile di gruppo fra le varie imprese controllate in funzione della loro partecipazione al ciclo complessivo.
Il metodo della comparazione dei profitti (c.d. comparable profit method), presuppone la determinazione del profitto lordo di ciascuna impresa in relazione alla percentuale del fatturato delle vendite o ai costi di esercizio rispettivamente sostenuti rispetto al totale.
Il metodo della comparazione della redditività del capitale investito o dei margini netti delle transazioni (c.d. transactional net margin method), presuppone la determinazione del profitto lordo di ciascuna impresa in relazione al capitale investito, a prescindere dai costi di produzione o di vendita.
Di particolare rilevanza è la scelta del metodo più appropriato. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 (che regola in merito al regime premiale di cui si dirà dopo) recependo l’impostazione delle Linee Guida OCSE richiede che, in caso di selezione di un metodo transazionale reddituale (Transactional net margin method e Transactional profit split method ), in presenza del potenziale utilizzo di un metodo tradizionale (Comparable uncontrolled price method, Resale price method e Cost plus method), oppure in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo, siano evidenziate le ragioni della mancata adozione dei metodi non selezionati.
In ogni caso occorre ricordare che quanto previsto dalle direttive OCSE al paragrafo 2.8 delle Linee Guida, ove si afferma che: “Le indicazioni di cui al par. 2.2 secondo le quali la selezione di un metodo per la determinazione del prezzo di trasferimento deve mirare a trovare il metodo più appropriato al caso specifico, non vanno intese nel senso che sia necessario analizzare in dettaglio o testare ogni volta ognuno dei metodi per la determinazione del prezzo di trasferimento per individuare quello più appropriato. Secondo un approccio corretto, la selezione del metodo più appropriato e dei comparabili dovrebbe essere dimostrata e può essere parte di un processo tipizzato quale quello proposto nel paragrafo 3.4.”
In merito si veda anche quanto detto nel paragrafo che tratta della redazione del “Documento Nazionale”.
Il ruling internazionale
Con l’art. 8 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il legislatore ha posto l’accento sulla tematica dei prezzi di trasferimento e, in ragione della complessità della fattispecie, ha introdotto la procedura del ruling di standard internazionale.
Articolo 8 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 - Ruling internazionale
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
La duplice finalità della procedura, realizzata mediante la stipulazione di un accordo tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente, è identificabile nel garantire, da un lato, all’impresa con attività internazionale, certezza in merito ai metodi di calcolo dei prezzi da praticarsi nell’ambito di operazioni concluse con imprese associate non residenti, dall’altro all’Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attivamente sul rispetto del principio di libera concorrenza da parte della stessa impresa con attività internazionale in via preventiva e senza dover ricorrere a mezzi di accertamento ordinari. E’ noto, infatti, come tali mezzi siano sovente suscettibili di generare contenzioso, in quanto un appuramento rigoroso ed esaustivo dell’effettivo rispetto delle condizioni di libero mercato nell’ambito di transazioni tra contribuenti residenti e imprese associate non residenti risulta particolarmente complesso.
Il regime premiale introdotto dal Dl 78 del 2010
Con l’art. 26 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, (rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”) è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di oneri documentali con riferimento ai prezzi di trasferimento.
E’ stato infatti inserito, all’art. 1 Dlgs n. 471 del 1997, il comma 2- ter con il quale il legislatore ha previsto la non applicabilità delle sanzioni connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7 da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, qualora il contribuente, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, consegni agli organi di controllo una specifica documentazione prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato in data 29 settembre 2010, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Articolo 1 Dlgs n. 471 del 1997
(…)
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.(…)
Il beneficio in questione, consiste nell’esclusione dell’applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 1 del Dlgs 471/1997 in caso di infedeltà della dichiarazione (nonché, per ragioni di coerenza sistematica, delle analoghe sanzioni previste per il comparto Irap). Detto beneficio è, pertanto, subordinato al realizzarsi della condizione, consistente nella consegna, da parte del contribuente, agli organi di controllo, di specifica documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati e che garantisca un più agevole espletamento delle operazioni di controllo.
Si tratta nella sostanza di un regime premiale che tiene conto dell’impegno profuso dai contribuenti che, in buona fede, predispongono la documentazione con l’effetto di agevolare, in sede di controllo, il riscontro della conformità al valore normale delle operazioni infragruppo realizzate.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 (prot. n. 2010/137654)
Con il Provvedimento sono stati individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato Codice di Condotta deliberato in data 27 giugno 2006 dal Consiglio dell’Unione Europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, gli elementi documentali la cui predisposizione e detenzione costituisce onere per le imprese soggette ex lege all’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, che vogliano beneficiare del regime di esenzione dall’irrogazione delle ordinarie sanzioni contemplate in caso di dichiarazione infedele.
Il Provvedimento fornisce indicazioni specifiche sul tipo di set documentale da predisporre al fine di fornire una corretta descrizione e valutazione delle operazioni con imprese associate tali da incrementare il livello di certezza sulla documentazione da detenere in vista di un eventuale controllo dell’amministrazione fiscale.
La normativa prevede, inoltre, a carico della società un obbligo di comunicazione in merito al possesso della documentazione prevista. Le modalità ed i termini di effettuazione di tale adempimento sono regolamentati nel Provvedimento del 29 settembre 2010 e variano a seconda che la documentazione si riferisca o meno ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010). Infatti, la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e ai successivi deve essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre quella concernente i periodi d’imposta antecedenti deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (e cioè, entro il 28 dicembre 2010), ovvero oltre tale termine, ma, in ogni caso, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
Qualora tali modalità e termini di presentazione della comunicazione non vengano rispettati dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria non potrà accordare il beneficio previsto dal comma 2-ter dell’art. 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Il Provvedimento chiarisce inoltre cosa debba intendersi per “documentazione idonea” che il contribuente deve predisporre al fine della disapplicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 1 del predetto decreto n. 471. La stessa è costituita da un documento denominato “Masterfile” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”.
Il regime documentale è stato, peraltro, diversificato a seconda che lo stesso venga adottato da una società holding, da una sub-holding o da una impresa controllata. Sono inoltre previste specifiche indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alleggerimenti dell’onere per le piccole e medie imprese, così come individuate secondo le definizioni che vengono fornite dal Provvedimento.
La disciplina in parola non ha introdotto un obbligo generalizzato, bensì un onere a carico del contribuente, al fine di incentivare l’adesione al regime in un’ottica di adempimento spontaneo. Invero, qualora il contribuente non predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione contemplata dal Provvedimento, lo stesso non sarà passibile di sanzioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle previste in via ordinaria dall’art. 1 Dlgs 471/1997 per il caso di infedele dichiarazione.
Ove, al contrario, il contribuente predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione idonea contemplata dal Provvedimento, ne dia rituale comunicazione all’Agenzia e, all’atto del controllo, la esibisca agli organi incaricati della conduzione dell’attività ispettiva, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni previste dall’art. 1 del Dlgs 471/1997 per il caso di infedele dichiarazione, ovviamente limitatamente ad eventuali recuperi a tassazione derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati.
In merito è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circ. 58/E del 15 dicembre 2010.
La comunicazione e gli oneri documentali
Per poter beneficiare del regime premiale occorre che:
1)che il possesso della documentazione sia comunicato anno per anno all’agenzia delle entrate;
2) la documentazione deve essere consegnata all’atto della verifica o, al più tardi, entro 10 giorni dalla richiesta.
Il Provvedimento, salve le specifiche previsioni per talune categorie di soggetti di cui si dirà in seguito, stabilisce, all’art. 2, che la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni infragruppo è costituita
- da un documento denominato “Masterfile”, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e
- da un documento denominato “Documentazione Nazionale” contenente informazioni relative alla singola società del gruppo multinazionale.
Si rileva che il sistema, per come impostato, assicura e dà piena garanzia agli altri stati membri della UE sul fatto che, in caso di necessità, i contenuti della documentazione detenuta da imprese italiane siano coerenti con quanto stabilito dal Codice di Condotta deliberato in data 27 giugno 2006 dal Consiglio dell’Unione Europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri.
L’Agenzia delle entrate nella cir. 58/E del 2010 evidenzia come il concetto di “idoneità” dei documenti, non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento, bensì a un’ottica più ampia e sostanzialistica, che premi l’attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. In altre parole, la documentazione potrà essere considerata “idonea” laddove sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida OCSE. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in esito a tale analisi, dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente.
Proprio alla luce di quanto detto, il punto 8.3 del Provvedimento precisa che la documentazione non può essere considerata idonea qualora, pur rispettando la struttura formale prevista, non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni previste nello stesso Provvedimento ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondano in tutto o in parte al vero. Tale contrappeso, finalizzato a scongiurare pratiche di strumentalizzazione del regime, deve tuttavia essere utilizzato in modo appropriato ed equilibrato in sede di controllo, al fine di evitare contestazioni indiscriminate in ordine all’idoneità della documentazione, che non tengano conto della natura della documentazione stessa e dell’impegno del contribuente.
L’Agenzia delle entrate nella cir. 58/E del 2010 puntualizzare che, sia con riferimento al Masterfile che alla Documentazione nazionale, la struttura dei capitoli, paragrafi e sottoparagrafi nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, a meno che non siano richieste modifiche parziali o integrazioni volte a consentire una migliore intelligibilità del documento.
Il paradigma che definisce il concetto di documentazione idonea espresso all’art. 2 del Provvedimento, come anticipato in premessa, risulta tuttavia diversificato a seconda della tipologia di soggetto interessato dalla norma in commento.
Tale diversificazione trova la sua ragion d’essere nell’assunto che il livello di informazioni richiesto ad un contribuente ai fini dell’assolvimento dell’onere deve essere proporzionato alla sua capacità effettiva di accesso alle informazioni stesse.
Il riconoscimento di tale principio di base ha portato ad una diversa graduazione dell’onere a seconda che il soggetto considerato sia
- una holding,
- una sub-holding (o una stabile organizzazione in Italia di una holding o di una sub-holding estera) residente in Italia oppure che
- si tratti di una impresa controllata (o una stabile organizzazione in Italia di una controllata estera), sempre residente a fini fiscali in Italia.
Occorre in ultimo segnalare che, in ragione del grado di complessità dell’attività e delle operazioni poste in essere da alcune imprese associate appartenenti a un gruppo multinazionale, il Provvedimento, rispettando l’impegno richiesto in ambito comunitario dal Codice di Condotta UE, ha stabilito per le piccole e medie imprese una semplificazione nella presentazione della documentazione che si sostanzia in un alleggerimento dell’onere documentale.
La comunicazione
L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 26 del decreto-legge prevede che: “il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento (…), deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati”.
I termini e le modalità relativi alla trasmissione della comunicazione differiscono a seconda che la documentazione si riferisca al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (ossia il 31 maggio 2010) e ai successivi periodi di imposta, oppure a quelli precedenti.
Per quanto riguarda
- i periodi di imposta a partire da quello in corso al 31 maggio 2010 (vale a dire 2010 e successivi), il punto 9.1. del Provvedimento dispone che il contribuente dovrà comunicare l’adozione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento con la dichiarazione annuale dei redditi.
- i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 maggio 2010 (vale a dire 2009 e precedenti), l’art. 26 del decreto-legge dispone che la comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento, ossia entro il 28 dicembre 2010, in via telematica tramite il servizio Entratel 5 , secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.
Si precisa che nel caso di comunicazione riguardante più periodi d’imposta pregressi, la trasmissione telematica dei dati potrà farsi mediante un unico invio o, alternativamente, con più comunicazioni inviate in tempi diversi, purché venga rispettato il termine previsto dal Provvedimento.
Nel caso di esercizi non coincidenti con l’anno solare e per i quali la data di chiusura sia compresa tra il 31 maggio 2010 e il 30 dicembre 2010, la comunicazione deve essere effettuata anche in tali casi tramite il servizio Entratel, ma entro i termini previsti per la relativa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento, inoltre, attribuisce validità alla comunicazione relativa a un periodo d’imposta pregresso, qualora la stessa sia stata trasmessa successivamente al 28 dicembre 2010, ma antecedentemente all’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie aventi ad oggetto il medesimo periodo d’imposta e delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza. Resta comunque impregiudicata la facoltà del contribuente di predisporre la documentazione, e comunicarne il possesso, qualora la stessa sia relativa a un periodo d’imposta diverso da quello oggetto di controllo.
REGIME TRANSITORIO
La Circ. 58/E del 2010, in applicazione del c.d. principio del “favor rei” (di cui all’art. 3 del 472/1997 - che informa il sistema sanzionatorio tributario e secondo il quale il nuovo regime premiale vale anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione più favorevole) prevede che:
- in presenza di attività istruttorie in corso o, comunque, non ancora perfezionatesi in un atto di accertamento, il contribuente, qualora intendesse accedere al regime di disapplicazione delle sanzioni previste dalla norma in commento, dovrà trasmettere la comunicazione di possesso della documentazione all’Agenzia delle entrate entro il 28 dicembre 2010.
- nelle ipotesi in cui siano stati già notificati atti di accertamento, l’applicazione del regime in parola dovrà basarsi su un appuramento del comportamento tenuto dal contribuente nel corso delle attività istruttorie antecedenti alla notifica dell’atto di accertamento, che abbia consentito il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, come, ad esempio, il fatto che lo stesso abbia consegnato nel corso di verifica una documentazione idonea secondo le modalità e i termini declinati in premessa al presente paragrafo.
Ciò avuto riguardo, in generale, alla circostanza che il principio del favor rei trova un limite soltanto nel fatto che, se la sanzione è già stata irrogata con un provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
Il contenuto del masterfile
Come precisato dal Provvedimento, il Masterfile raccoglie le informazioni relative al gruppo.
È consentita la presentazione di più Masterfile qualora il gruppo operi in modo diversificato, in differenti settori di attività (o linee di business) disciplinati da specifiche politiche di transfer pricing.
Ci si riferisce, ad esempio, al caso dei gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata ovvero costituita da divisioni con linee di attività e/o politiche in materia di prezzi di trasferimento diverse. La previsione richiamata risponde pertanto all’esigenza di consentire alle imprese di documentare la propria politica di prezzi di trasferimento, segregando l’analisi in modo appropriato, venendo in tal modo incontro a esigenze di chiarezza delle analisi nonché di omogeneità e confrontabilità delle informazioni fornite.
Le informazioni da riportare nel Masterfile sono le seguenti:
1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
Storia, evoluzione recente, settori di operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento.
2. Struttura del gruppo
2.1. Struttura organizzativa: organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del gruppo e relative quote partecipative.
2.2. Struttura operativa: con evidenza della descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito delle attività del gruppo.
Sul punto la circ. n. 58/E del 2010 precisa che – ai fini della descrizione sommaria del “ruolo” che ciascuna impresa associata svolge nell’ambito delle attività del gruppo – non è sufficiente la mera apposizione, a fianco del nome dell’impresa, di una semplice etichetta riassuntiva (i.e. “contract manufacturer”, “limited risk distributor”,
ecc.). La descrizione, infatti, per quanto sommaria deve essere fornita mediante una esposizione succinta del profilo funzionale e operativo del soggetto, in relazione all’operatività complessiva del gruppo e a quella
delle altre società o imprese del gruppo con cui l’entità oggetto della descrizione si relaziona.
3. Strategie generali perseguite dal gruppo (con particolare riferimento alle strategie di sviluppo e consolidamento) ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente.
La circ. n. 58/2010 ritiene insufficienti le descrizioni delle “Strategie generali perseguite dal gruppo” esposte in maniera generica e succinta, senza alcun riferimento ad evidenze documentate e/o documentabili e/o oggettivamente riscontrabili.
4. Flussi delle operazioni, incluse le modalità di fatturazione e i relativi importi, le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi.
Le transazioni dovranno essere descritte in un diagramma di flusso che ricomprende anche quelle relative ad operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria. Ciò implica anche l’evidenza delle informazioni relative alla struttura dei flussi derivanti, ad esempio, da operazioni di business restructurings definite dal nuovo capitolo IX delle Guidelines come “the cross-border redeployment by a multinational enterprise of functions, assets and/or risks”.
Sul punto, la circ. n. 58/2010 chiarisce che il Masterfile deve fornire un quadro generale dei flussi delle operazioni infragruppo rientranti nell’ambito di applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento. Si ritiene che, in tale capitolo, debbano essere anche descritte eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti, qualora assimilabili o aventi la stessa natura di quelle infragruppo. Le operazioni infragruppo dovranno essere sintetizzate in un diagramma che sia in grado di dare evidenza della struttura e della dinamica dei flussi delle operazioni all’interno del gruppo multinazionale. A tal proposito il Provvedimento precisa che il diagramma dovrà prendere in considerazione tutte le operazioni, ivi incluse quelle non riconducibili alla gestione ordinaria ed aventi dunque carattere di straordinarietà, eccezionalità o unicità. La rappresentazione grafica dei flussi delle operazioni infragruppo dovrà essere ulteriormente chiarita descrivendo le modalità e i flussi di fatturazione delle operazioni e i relativi importi, nonché la logica economico-giuridica che ha indotto a strutturare la dinamica dei flussi come rappresentata. Occorre chiarire che tale ordine di motivazione risponde a una duplice esigenza: da un lato si ricollega a elementi della cd. prima parte del Masterfile (capitoli da 1 a 3) e, pertanto, rappresenta una sorta di cerniera tra l’oggetto dell’attività, e relativo assetto organizzativo, e le modalità con le quali tale attività si estrinseca nei connessi flussi di operazioni; dall’altro risponde anche all’esigenza di consentire al contribuente di declinare motivazioni utili a sostenere la coerenza tra forme giuridiche adottate e le operazioni effettivamente poste in essere. Occorre segnalare, tuttavia, che l’eventuale non riconoscimento delle forme giuridiche adottate rispetto alla sostanza delle operazioni poste in essere rappresenta, in base alle Linee Guida OCSE (v. par. 1.64-1.69) e al di fuori di ipotesi abusive, una eccezione alla regola generale, in base alla quale l’amministrazione è tenuta a riconoscere le forme giuridiche utilizzate dalle parti nella strutturazione delle proprie operazioni.
5. Operazioni infragruppo.
5.1. Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari: (per ogni tipologia di transazione si dovranno fornire i seguenti dettagli:
(i) natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea;
(ii) soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente punto 2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni e i servizi descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno essere trattate unitariamente in conformità a quanto previsto dalle Guidelines OCSE).
Secondo la circ. n. 58/2010, tale paragrafo deve articolarsi in tanti sottoparagrafi quante sono le tipologie di operazioni infragruppo. Ognuno dei sottoparagrafi dovrà fornire informazioni circa la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea. Per ogni tipologia di operazione, inoltre, si dovrà precisare quali dei soggetti elencati al capitolo 2 (parte relativa alla struttura organizzativa del gruppo) hanno preso parte alle operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. Occorre inoltre segnalare che il riferimento alla possibilità di trattare unitariamente categorie omogenee di beni e servizi va interpretato in maniera coerente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE e con la scelta dei metodi di valorizzazione delle operazioni adottati. Per ragioni di coerenza sistematica, tale impostazione vale anche per i servizi e gli accordi per la ripartizione di costi di cui alle operazioni indicate ai paragrafi 5.2 e 5.3.
5.2. Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo: il Provvedimento richiede di indicare con “sufficiente precisione” le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di una o più associate.
Secondo la circ. n. 58/2010, tale paragrafo deve articolarsi in tanti sottoparagrafi quante sono le tipologie di servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo. Per servizi funzionali resi da una o più associate a beneficio di una o più delle altre associate si intendono i servizi di cui al capitolo VII rubricato “Special consideration for Intra-Group Services” delle Linee Guida OCSE (v. paragrafi 7.14, 7.22 e 7.27). A titolo di esempio, sono considerati servizi funzionali ai fini delle presenti istruzioni, quelli da cui originano le spese di regia ossia le spese relative a servizi infragruppo accentrati (quali, ad esempio, gestione della tesoreria, marketing, gestione delle IT). In ciascun sottoparagrafo si dovrà dare indicazione della natura dei servizi oltre ad una precisa definizione delle caratteristiche dei servizi di cui trattasi, degli accordi tra le parti per la ripartizione dei costi derivanti dalla prestazione dei servizi in commento. Per ogni tipologia di servizio, si dovrà precisare quali dei soggetti appartenenti al gruppo ed elencati al capitolo 2 relativo alla struttura organizzativa del gruppo, hanno preso parte alle operazioni descritte.
In termini generali si osserva, ad esempio, che le modalità di riaddebito delle spese di regia (nonché dei servizi infragruppo) devono essere oggettive e documentabili, in modo da evitare, per quanto possibile, le censure di eventuali organi di controllo.
I requisiti di oggettività e di dimostrabilità sono tanto più verificabili quanto maggiore è il grado di formalizzazione degli accordi intervenuti e dei criteri concretamente applicati.
Quanto all’oggettività, è opportuno fare riferimento alla necessità di:
– operare in analogia, ove possibile, con i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento i beni materiali;
– individuare con puntualità il criterio adottato nel caso concreto (anche per giustificare eventuali inapplicabilità dei metodi tradizionali);
– rendicontare i costi e i tempi di prestazione dei servizi;
– rendicontare l’utilità conseguita in seno al gruppo dalle singole consociate che hanno fruito dei servizi, almeno nel senso che il costo riaddebitato dovrebbe essere, in linea di principio, inferiore a quello che si sarebbe sostenuto acquisendo i medesimi servizi da prestatori terzi;
– circostanziare tutti gli elementi in grado di dimostrare l’applicazione del principio di libera concorrenza;
5.3. Accordi per la ripartizione di costi: deve riportare, oltre all’elenco completo degli accordi per la ripartizione di costi, l’indicazione, per ciascuno, del relativo oggetto, della durata dell’accordo, dei soggetti partecipanti, del perimetro delle attività e dei progetti coperti.
6. Funzioni svolte, assets utilizzati e rischi assunti.
Descrizione generale delle funzioni svolte, degli assets e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da
operazioni di business restructurings come precedentemente definite.
Secondo la circ. n. 58/2010, tale capitolo accoglie informazioni in merito alle funzioni svolte, ai beni strumentali impiegati e i rischi assunti da ognuna delle imprese associate coinvolte nelle operazioni infragruppo dando evidenza dei cambiamenti intervenuti rispetto al periodo di imposta precedente sia nelle funzioni svolte, sia nei beni strumentali utilizzati sia nei rischi assunti dalle singole imprese.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai cambiamenti intervenuti a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. E’ di tutta evidenza che, con riferimento ai beni strumentali, non viene richiesta una minuziosa elencazione di ogni singola variazione intervenuta a seguito di dismissioni o acquisto di singoli cespiti, bensì un’indicazione di massima di mutamenti rilevanti nella composizione e nel peso dei beni strumentali complessivamente considerati, allocati presso le singole entità del gruppo.
7. Beni immateriali.
Intangibles detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali royalties, distinte per soggetto percipiente o erogante, corrisposte per lo sfruttamento degli stessi.
Secondo la circ. n. 58/2010, tale capitolo è destinato alla trattazione dei beni immateriali detenuti da ogni singola impresa associata coinvolta nelle operazioni infragruppo. Di tali beni dovrà essere fornito un elenco completo con separata indicazione di eventuali canoni corrisposti per l’utilizzo degli stessi specificando il soggetto percipiente ed erogante. Si precisa che, tenuto conto dell’importanza che i beni immateriali assumono ai fini della valutazione della correttezza dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle imprese multinazionali, dovrà essere data descrizione anche di eventuali intangibles non iscritti in bilancio. Ci si riferisce, per esempio, al know how di processo, agli effetti positivi generati dalle sinergie, agli effetti positivi di network e così via. Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che alla proprietà e al momento della creazione dei beni, ad eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale che abbiano comportato una riallocazione dei beni immateriali.
8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo.
descrizione della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e delle ragioni per le quali la stessa si ritenga essere conforme all’arm’s length principle. A sostegno di tali informazioni, occorrerà fornire anche sintetica menzione dell’esistenza e dei contenuti essenziali di contratti a base della politica di pricing adottata.
Secondo la circ. n. 58/2010, tale capitolo il capitolo 8 del Masterfile descrive la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e offre evidenza delle ragioni per le quali la politica adottata dal gruppo viene ritenuta conforme al principio di libera concorrenza. Nell’ambito della trattazione si dovranno fornire informazioni circa i contratti stipulati dalle imprese associate del gruppo sui quali la politica sui prezzi di trasferimento si basa approfondendo l’analisi attraverso una descrizione della natura dei contratti, dei contraenti e una sintesi del contenuto degli stessi.
9. Rapporti con le Amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti “Advance Pricing Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento.
Il Masterfile si conclude con una sintetica descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, siano essi gli “ Advance Price Arrangements” (APA) ovvero ruling rispettivamente sottoscritti con o rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità.
Il contenuto della documentazione nazionale
I primi quattro capitoli della Documentazione Nazionale (1. Descrizione generale della società; 2. Settori in cui opera la società; 3. Struttura operativa della società; 4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente) compongono idealmente una prima parte della Documentazione Nazionale, in quanto sono destinati a fornire un quadro generale della società. La seconda parte, rappresentata dai successivi capitoli, descrive le operazioni infragruppo oggetto della documentazione e, per ciascuna tipologia di operazioni (qualora ve ne fosse più di una), trova illustrazione l’analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi trasferimento, nonché le connesse analisi economiche e i risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
La Documentazione Nazionale contiene le informazioni relative alla società:
1. Descrizione generale della società.
Storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento.
2. settori in cui opera la società.
3. Struttura operativa della società.
Descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle business units dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività.
4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente: informazioni relative anche a specifiche strategie legate a particolari settori o mercati.
La circ. n. 58/2010 precisa che la struttura generale della Documentazione Nazionale non differisce sostanzialmente da quella del Masterfile, salvo rilevare che la stessa si riferisce unicamente alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno del gruppo e alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o in parte la sua attività.
5. Operazioni infragruppo, quali le cessioni di beni materiali o immateriali, le prestazioni di servizi, le prestazioni di servizi finanziari: le informazioni da inserire devono essere relative a tutte le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. È richiesta la definizione con sufficiente precisione della natura delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi oggetto di trattazione, ivi inclusi i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate, nonché i relativi importi e le motivazioni economiche/giuridiche alla base della struttura dei flussi.
Secondo la Cir. 58/E del 2010, nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni intercorse tra la società e gli altri soggetti del gruppo in maniera da fornire un primo quadro sintetico delle operazioni descritte in maniera più ampia e precisa nei successivi paragrafi. In tale ambito, si dovrà dare evidenza, in maniera dettagliata, dei flussi delle operazioni infragruppo, ivi inclusi i relativi importi, descrivendo la logica economico-giuridica sottesa alla scelta di conferire alle attività della società la struttura già rappresentata nel diagramma di flusso. A tal fine, il Provvedimento prevede che alla Documentazione Nazionale debba essere allegato un diagramma di flusso che sintetizzi quanto descritto nell’ambito del capitolo 5 in commento. Si osserva che, il contribuente è tenuto a dare indicazione di tutte le operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 110 c. 7 del Tuir.
Il capitolo descrive le operazioni infragruppo, siano esse cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi o prestazioni di servizi finanziari. Nella struttura del capitolo dovranno essere previsti tanti paragrafi quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Ogni paragrafo dovrà descrivere, con precisione, i beni e/o i servizi oggetto delle operazioni trattate oltre che i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate. In analogia a quanto rilevato in merito al Masterfile, anche per la Documentazione Nazionale vale il riferimento alla possibilità di trattare unitariamente categorie omogenee di beni e servizi in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee Guida OCSE.
Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi si osserva che alcune indicazioni in merito alla documentazione da predisporre a supporto dell’effettiva prestazione dei servizi sono state fornite dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sent. n. 158 del 29 luglio 2005, avente ad oggetto la deducibilità dei costi per servizi infragruppo resi da un centro di servizio europeo; aveva individuato gli elementi necessari a dimostrare l’effettività e l’inerenza di tali costi ai sensi dell’art. 109 del Tuir:
– esistenza di un contratto da cui si rilevino chiaramente i servizi prestati e le relative modalità di prestazione;
– regolare fatturazione alla società beneficiaria e contabilizzazione da parte della stessa dei costi sostenuti per l’ottenimento del servizio;
– presenza di documentazione contabile della società fornitrice dei servizi che attesti l’ammontare dei costi sostenuti;
– presenza di una relazione di certificazione emessa da una primaria società di revisione che attesti i costi sostenuti nella prestazione dei servizi;
– produzione di documentazione atta a supportare l’effettività del servizio reso e il beneficio reso.
Passando ai punti successivi, il Provvedimento prevede la predisposizione di uno specifico paragrafo (da 5.1 a 5.n), per ogni operazione infragruppo. Nel seguito si riportano specifiche indicazioni in relazione ai contenuti dei relativi sottoparagrafi atte a fornire informazioni in ordine alle medesime operazioni (sottoparagrafi declinati, nel Provvedimento, con la numerazione da 5.1.1 a 5.1.3).
Per ogni operazione devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) 5.n.1. Descrizione delle entità del gruppo con le quali le transazioni sono poste in essere
b) 5.n.2 Analisi di comparabilità
c) 5.n.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni
a) 5.n.1. Descrizione delle entità del gruppo con le quali le transazioni sono poste in essere (stessa indicazione deve essere fornita anche quando tali transazioni sono realizzate con soggetti indipendenti).
Secondo la Cir. 58/E del 2010, il sottoparagrafo in commento è destinato ad accogliere la descrizione della tipologia di operazioni presa in esame, unitamente all’indicazione delle relative controparti da distinguersi tra imprese associate e imprese diverse da quelle associate (il richiamo, posto nel Provvedimento tra parantesi quadra, a soggetti indipendenti è infatti da intendersi riferito a soggetti estranei al gruppo multinazionale di appartenenza, sia che si tratti di soggetti appartenenti a loro volta a gruppi, sia che si tratti di soggetti non appartenenti ad alcun gruppo). Ogni tipologia di operazione dovrà essere corredata dalla descrizione della natura e delle relative modalità di svolgimento. Anche in questo caso si dovrà avere cura di distinguere le operazioni condotte nei confronti di imprese associate da quelle intrattenute con soggetti terzi rispetto al gruppo di appartenenza.
b) 5.n.2 Analisi di comparabilità (coerente con i cinque fattori di comparabilità contemplati dalle Guidelines OCSE).
Il cuore del Documento nazionale è certamente il capitolo in cui il contribuente deve descrivere il percorso di esame della transazione controllata per esplicitarne le caratteristiche peculiari rispetto ai fattori rilevanti di comparazione (cosiddetti 5 fattori di comparabilità) , per stabilire, infine, i parametri entro i quali ricercare operazioni simili tra soggetti indipendenti e definire il metodo per il calcolo del corretto prezzo di trasferimento. Coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida OCSE, l’analisi di comparabilità costituisce una delle parti fondamentali nel processo di determinazione dei prezzi di trasferimento e, pertanto, assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale. A tal fine, al punto 2.2, il Provvedimento individua nel sottoparagrafo in commento i cosiddetti cinque fattori della comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari.
Trattasi, nella specie dei seguenti fattori:
a) Caratteristiche dei beni e dei servizi : identificazione e comparazione di caratteristiche fisiche/natura, qualità, volumi di vendita, canali di approvvigionamento, eccetera;
b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati: identificazione e comparazione delle principali funzioni esercitate (ideazione/R&D, produzione, approvvigionamento, distribuzione, pubblicità e marketing, eccetera), assets impiegati (impianti, beni immateriali), rischi assunti (investimenti/R&D, mercato, credito, tasso, eccetera);
c) Termini contrattuali: identificazione della modalità effettiva di esecuzione delle transazione, della ripartizione dei rischi e della remunerazione;
d) Aspetti / condizioni economiche: identificazione e comparazione delle caratteristiche dei mercati di riferimento (localizzazione geografica, dimensioni, grado di concorrenza, posizione concorrenziale relativa, stadio di commercializzazione, eccetera);
e) Strategie di business: identificazione delle politiche strategiche che incidono sulla determinazione del prezzo.
Se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della documentazione si basi in misura rilevante su un’analisi di comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata, dall’altro la Cir. 58/E del 2010 rileva che l’importanza relativa dei predetti fattori di comparabilità, come anche riconosciuto dalle Linee Guida OCSE, varia in relazione al metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale ultimo aspetto vale, in particolare, in presenza di analisi basate su operazioni comparabili esterne.
Le imprese, nella compilazione del capitolo 5 del Documento nazionale, non devono fare altro che documentare l’approccio metodologico adottato e le scelte effettuate, motivandole adeguatamente.
Particolare attenzione andrà posta sulle eventuali transazioni realizzate nei confronti di soggetti terzi indipendenti che possono essere considerate ad una prima analisi analoghe a quelle intercompany (comparabili
interni): l’obiettivo, innanzitutto, dovrà essere quello di capire se le stesse possano essere utilizzate per la determinazione del prezzo di trasferimento in conformità col principio di libera concorrenza, una volta confermata l’omogeneità di caratteristiche con quelle infragruppo; in caso contrario, occorrerà dare evidenza degli elementi sostanziali che differenziano le due categorie di transazioni a tal punto da escludere la possibilità di procedere con il confronto interno.
Con riferimento all’analisi di comparabilità è opportuno svolgere alcune (Cfr. Transfer pricing: Primi chiarimenti in materia di oneri di documentazione in Italia, P. Valente, “Il fisco” n. 2 del 10 gennaio 2011, pag. 1-219) . In termini generali si rileva che le Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE (Cap. III “Comparability Analysis) identificano un tipico processo di selezione dei comparabili che include i seguenti steps:
– step 1: identificazione degli anni oggetto di analisi;
– step 2: un’analisi generale (broad-based analysis) relativa alle circostanze afferenti il contribuente;
– step 3: understanding delle transazioni controllate oggetto di analisi in relazione all’analisi funzionale svolta, al fine di selezionare la tested party, “the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of
the case” e gli indicatori finanziari e di identificare i fattori di comparabilità oggetto di valutazione;
– step 4: review dei comparabili interni nel caso in cui esistano;
– step 5: identificazione delle fonti di informazione relative ai comparables esterni;
– step 6: scelta del transfer pricing method in relazione alle circostanze del caso di specie e conseguente selezione degli indicatori finanziari (in caso di applicazione del TNMM, determinazione del net profit indicator);
– step 7: identificazione dei potenziali comparabili, con particolare riferimento alle caratteristiche delle transazioni indipendenti, rilevate secondo lo step 3 e conformemente a quanto previsto dalle Guidelines
dell’OCSE nei paragrafi 1.38-1.63;
– step 8: effettuazione degli aggiustamenti, ove richiesti;
– step 9: “interpretazione” dei dati ottenuti e determinazione della remunerazione at arm’s length.
Focalizzando l’attenzione sulla selezione di soggetti comparabili esterni (di cui allo step n. 5), le Guidelines evidenziano l’esistenza di diverse fonti di informazione:
– database commerciali, che possono essere utilizzati per svolgere una ricerca sia su base locale che su base multi-country;
– dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria interessata che derivano da accertamenti compiuti su altri contribuenti o da fonti non accessibili al contribuente (trattasi, nel caso di specie, dei c.d. secret comparables).
L’approccio che fa ricorso alle informazioni contenute nel database per la selezione dei comparables è quello che viene identificato dall’OCSE come deductive approach: “the «deductive approach» starts with a wide set of companies that operate in the same sector of activity, perform similar broad functions and do not present economic characteristics that are obviously different. The list is then refined using publicly available information (databases, internet sites, taxpayer’s knowledge of its competitors) and, in particular, using qualitative criteria such as those relating to product portfolios and business strategies”.
Il ricorso a tale approccio rende necessaria, da parte del contribuente, la predisposizione della documentazione atta a supportare i criteri di selezione utilizzati per l’inclusione/esclusione di soggetti terzi, nonché a garantire un adeguato livello di trasparenza ed oggettività.
Con riferimento a tale ultimo aspetto si ritiene opportuno evidenziare che gli steps devono essere “riproducibili” da parte dell’Amministrazione finanziaria che intende ripetere la selezione.
Pertanto, l’approccio in esame presenta un grado di affidabilità maggiore in termini di trasparenza, oggettività e “riproducibilità”.
Nella selezione dei comparabili esterni (non necessariamente i competitors sono anche comparables) occorre tenere in debita considerazione quanto previsto dallo step di selezione n. 2 con riferimento alle
circostanze afferenti il contribuente.
L’OCSE, inoltre, afferma che due transazioni sono comparabili se viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
– nessuna delle differenze (se esistono) tra letransazioni comparate può sostanzialmente influenzare il prezzo riconosciuto alla transazione;
– l’effetto di tali differenze, se significativo ai fini della determinazione del prezzo, può essere eliminato con opportuni “aggiustamenti”.
Accanto alle differenze riguardanti in maniera specifica le transazioni in esame, occorre, inoltre, tenere in considerazione quelle relative alle imprese coinvolte nelle transazioni stesse.
A tal fine, la determinazione del grado di comparabilità e le operazioni volte all’effettuazione delle opportune correzioni di prezzo necessitano di un lavoro di confronto delle caratteristiche intrinseche alle transazioni esaminate, nonché alle imprese che le pongono in essere.
L’analisi verte su talune verifiche inerenti i c.d. “fattori di comparabilità”:
– caratteristiche dei beni/servizi: la nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines chiarisce che differenze nelle caratteristiche dei beni e/o servizi possono influenzare la concreta applicazione dei metodi; in tal senso, si rileva che i metodi reddituali risultano essere meno “sensibili”, rispetto ai metodi tradizionali, all’esistenza di differenze nelle suddette caratteristiche;
– analisi funzionale: si rileva la possibilità di procedere ad aggiustamenti nel caso in cui esistano differenze significative tra la “tested party” e i soggetti terzi. In ogni caso, occorre valutare il significato economico delle funzioni svolte dai soggetti coinvolti in termini di frequenza, natura e valore;
– condizioni contrattuali: nella pratica, risulta assai complesso acquisire informazioni relative ai termini contrattuali stabiliti tra soggetti terzi. L’effetto di eventuali lacune (se non della totale assenza di informazioni) deve essere valutato in relazione alle caratteristiche della transazione in esame e al metodo selezionato;
– circostanze di carattere economico: le nuove Guidelines dell’OCSE pongono particolare enfasi sulle caratteristiche del mercato di riferimento ed, in particolare, sull’ampiezza del mercato/dei mercati in cui opera il
gruppo multinazionale. Nel caso in cui, in relazione a determinati settori merceologici, i Paesi in cui opera il gruppo possono essere considerati ragionevolmente omogenei è possibile procedere ad un’analisi multi-country
al fine di supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata. In ogni caso, l’identificazione del mercato di riferimento deve essere considerata come una “factual question”;
– strategie commerciali: l’OCSE ha espresso particolari considerazioni in merito alla “sostenibilità” temporale ed economica di una strategia, considerando il giusto bilanciamento tra la redditività attesa e i costi sostenuti in un’ottica at arm’s length.
c) 5.n.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni (in conformità al nuovo standard di selezione e applicazione dei metodi previsto dall’OCSE, il metodo prescelto dovrà essere “the most appropriate method to the circumstances of the case”).
La parte centrale del provvedimento, e cioè il fulcro di qualunque politica, sta nell’individuazione del metodo più appropriato. Il sottoparagrafo accoglie il processo di selezione, e relativi esiti, del metodo che il contribuente ritiene, sulla base dell’analisi di comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più appropriato alle circostanze del caso.
In particolare, sono previste le seguenti tre sezioni:
a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
b) Criteri di applicazione del metodo prescelto.
c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza (in conformità al nuovo standard di selezione e applicazione dei metodi previsto dall’OCSE, il metodo prescelto dovrà essere “the most appropriate method to the circumstances of the case”).
Secondo la Cir. 58/E del 2010, la sezione dovrà dare contezza degli esiti dell’analisi di comparabilità, nonché delle informazioni disponibili, e dei relativi effetti in ordine alla scelta del metodo. Più in particolare, tale sezione dovrà illustrare le ragioni che hanno portato a qualificare il metodo prescelto per la determinazione dei prezzi di trasferimento come il metodo più appropriato alle circostanze del caso. Occorre altresì rilevare che, qualora sulla base delle informazioni desumibili dall’analisi di comparabilità, dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transazionale reddituale (Transactional net margin method e Transactional profit split method ) e, in maniera egualmente affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (Comparable uncontrolled price method, Resale price method e Cost plus method), il Provvedimento recepisce l’impostazione di cui alle Linee Guida OCSE, prevedendo l’utilizzo di tale ultimo metodo. Per tale ragione, in presenza delle condizioni suddette, qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in ipotesi applicabile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni. Tali motivazioni, di contro, non devono essere addotte, laddove l’analisi di comparabilità non dovesse fornire evidenze in merito al potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale in misura altrettanto affidabile. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled price), in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo.
In altre parole il provvedimento richiede che, in caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo tradizionale,oppure in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo, siano evidenziate le ragioni della mancata adozione dei metodi non selezionati.
In ogni caso occorre ricordare che quanto previsto dalle direttive OCSE al paragrafo 2.8 delle Linee Guida, ove si afferma che: “Le indicazioni di cui al par. 2.2 secondo le quali la selezione di un metodo per la determinazione del prezzo di trasferimento deve mirare a trovare il metodo più appropriato al caso specifico, non vanno intese nel senso che sia necessario analizzare in dettaglio o testare ogni volta ognuno dei metodi per la determinazione del prezzo di trasferimento per individuare quello più appropriato. Secondo un approccio corretto, la selezione del metodo più appropriato e dei comparabili dovrebbe essere dimostrata e può essere parte di un processo tipizzato quale quello proposto nel paragrafo 3.4.”
E’ di tutta evidenza, comunque, che l’eventuale sindacato in sede di verifica della scelta del metodo e/o delle ragioni addotte dal contribuente a difesa delle proprie scelte, in nessun caso costituisce presupposto autonomamente idoneo all’esclusione dal regime premiale stabilito dalla norma.
La ratio del Transactional Profit Split risiede, in primis, nella circostanza per la quale possono sussistere alcune differenze tra le transazioni controllate e le transazioni indipendenti, dovute all’esistenza di un’integrazione verticale tra le società appartenenti ad un gruppo multinazionale.
Infatti, nella pratica, la rilevazione di margini elevati tra società appartenenti ad un gruppo multinazionale è riconducibile alla riduzione dei costi connessi alle transazioni, all’integrazione tra i diversi processi (management, planning, administration), alla centralizzazione del risk management conseguente all’integrazione verticale tra le varie entità che compongono il gruppo (i.e. upstream entities e downstream entities).
Con riferimento allo status di “last resort methods” dei Transactional Profit Methods, il Working Party dell’OCSE aveva chiarito quanto segue:
– la selezione di un metodo è volta alla corretta determinazione di una metodologia appropriata per la determinazione del transfer pricing per ogni caso di specie;
– la selezione deve essere effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche di ogni metodo accettato dall’OCSE, l’adeguatezza del metodo rispetto all’analisi di comparabilità (e all’analisi funzionale) delle transazioni controllate, la disponibilità delle informazioni relative a transazioni comparabili indipendenti al fine di applicare il metodo selezionato, il grado di comparabilità esistente tra le transazioni controllate e le transazioni indipendenti e l’affidabilità degli aggiustamenti da (eventualmente) applicare al fine di eliminare le
differenze esistenti tra le transazioni in verifica.
Il nuovo standard delle Guidelines emanate il 22 luglio 2010 è volto alla selezione del metodo più idoneo considerando il caso di specie e le transazioni oggetto di analisi.
Il Transactional Net Margin Method (TNMM) consente di esaminare l’utile netto riferito a una base appropriata – costi, vendite, attività – che l’impresa realizza in una transazione infragruppo o in un gruppo di transazioni (qualora sia possibile procedere all’aggregazione delle transazioni secondo quanto previsto dai paragrafi 1.42 e seguenti delle Guidelines). Con riferimento a tale metodo, valgono i concetti applicabili al prezzo di rivendita e al costo maggiorato poiché i principi di funzionamento sono simili. Infatti:
– il margine netto di una transazione controllata è confrontato con quella che l’impresa realizza in transazioni comparabili con soggetti terzi (trattasi pertanto del confronto interno);
– ove ciò non fosse possibile, il margine netto realizzato in transazioni simili tra soggetti indipendenti può servire da guida.
Il maggior pregio di tale metodo risiede nella possibilità di utilizzarlo anche quando risulta difficoltosa l’applicazione dei metodi tradizionali in presenza di differenze nelle transazioni e delle funzioni che non possono essere eliminate attraverso aggiustamenti; infatti, i margini netti sono meno influenzati da differenze riscontrabili nelle transazioni (che incidono sui prezzi) e nelle funzioni (che incidono sui margini lordi).
Le diversità funzionali si riflettono spesso in variazioni delle spese operative: ne consegue che, per funzioni distinte, a margini lordi diversi, possono corrispondere margini netti uguali.
Per converso, il maggior difetto del metodo consiste nella difficoltà di determinare il valore di libera concorrenza poiché i margini netti sono influenzati da fattori che non incidono sui prezzi o sui margini lordi. Infatti:
– i margini netti sono influenzati dalle spese operative che variano considerevolmente tra le imprese;
– i margini netti sono soggetti agli effetti prodotti dalle forze attive nel settore economico in cui opera l’impresa.
Nell’applicare il TNMM occorre prestare attenzione a:
– calcolare correttamente gli indici finanziari da confrontare;
– selezionare transazioni comparabili a quelle oggetto di analisi;
– scegliere per la verifica una società del gruppo che non possieda beni (immateriali) unici.
Il metodo può essere utilizzato per valorizzare funzioni di routine (i.e. funzioni a basso valore aggiunto) come ad esempio la produzione, la distribuzione o altre e si fonda sulla comparabilità dei fattori produttivi impiegati piuttosto che su quella delle funzioni svolte, dei rischi assunti o dei prodotti oggetto della transazione (fermo restando che un certo grado di comparabilità delle funzioni e dei prodotti è comunque richiesto).
Il principio economico su cui si basa è il seguente: se il mercato dei fattori produttivi è in equilibrio, il rendimento del capitale (o di fattori produttivi simili) in relazione alle diverse tipologie di attività e tenendo in considerazione il diverso livello di rischio dovrebbe tendere ad eguagliarsi.
Ai fini dell’applicazione del metodo si richiede la comparabilità in:
– capacità imprenditoriale;
– composizione del capitale;
– dimensione delle operazioni;
– efficienza manageriale;
– struttura dei costi;
– posizione nel ciclo produttivo.
Aggiustamenti nei rendimenti netti possono essere effettuati al fine di contemplare differenze nei citati fattori secondo i principi esposti dall’OCSE con riferimento all’applicazione dei metodi tradizionali.
Un cenno a parte meritano i servizi funzionali infragruppo, tipicamente l’attività di ricerca e sviluppo, i servizi contabili ed amministrativi, finanziari, legali, di consulenza informatica, assistenza tecnica, marketing, che dovranno trovare adeguata rappresentazione nel Documento nazionale. Relativamente a detti servizi, si avrà cura di descrivere dettagliatamente l’interesse specifico dell’utilizzatore a ricevere quel servizio nell’ambito del gruppo, il contesto in cui il servizio viene reso, il grado di autonomia che il beneficiario potrebbe avere in assenza di supporto dal gruppo, il processo di valorizzazione con particolare riguardo alla scelta della configurazione di costo, del driver di ripartizione (ove vi sia una pluralità di soggetti a beneficiare del medesimo servizio) e della percentuale di mark-up operata.
b) Criteri di applicazione del metodo prescelto.
Tale sezione deve illustrare i criteri di applicazione del metodo prescelto, ivi incluso il procedimento di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili ed i singoli passaggi intermedi del procedimento, corredati dei relativi esiti. Secondo la Cir. 58/E del 2010, la sezione dovrà dare conto puntuale anche della fonte di dati e informazioni eventualmente utilizzati e, se del caso, dovrà parimenti essere data chiara indicazione dell’eventuale intervallo di risultati ritenuti conformi al principio del valore normale e delle ragioni sottese alla sua identificazione;
c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
La sezione dovrà rendere conto del confronto tra la valorizzazione attribuita alle operazioni infragruppo realizzate nel periodo d’imposta di riferimento e i valori riscontrati in esito alla procedura di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili.
6. Operazioni infragruppo.
Vanno illustrati gli Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” (“Cost Contribution Arrangements”) a cui l’impresa partecipa. Valgono, anche in tal caso, per quanto compatibili, le indicazioni delle Linee Guida OCSE. Occorre dare indicazione:
6.1. soggetti, oggetto e durata del CCA;
6.2. perimetro delle attività e progetti coperti;
6.3. metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti all’accordo e relative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti;
6.4 forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi;
6.5 formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dall’accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso;
6.6 previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze;
6.7. mutamenti intervenuti medio tempo nell’accordo.
Il Provvedimento specifica inoltre che alla Documentazione Nazionale (e non anche al Masterfile) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- all. 1 diagrammi di flusso relativi alle transazioni infragruppo, nonché alle transazioni non afferenti all’area ordinaria (ad esempio le transazioni poste in essere a seguito di operazioni di business restructurings);
- all. 2 copia dei contratti che disciplinano le transazioni poste in essere (vale a dire i contratti scritti in base ai quali le operazioni infragruppo e i cost contribution agreements sono regolate).
È possibile includere nel masterfile le informazioni richieste per il
Documento nazionale, sempre che le dette informazioni siano complete
rispetto a quelle previste per quest’ultimo documento.
La diversificazione dell’onere documentale a seconda del contribuente
Il Provvedimento, agli articoli da 3 a 5, ha disciplinato, attraverso specifiche previsioni, le modalità di adempimento dell’onere documentale a seconda della tipologia di soggetto interessato. In particolare, è stata prevista una diversificazione dell’onere a seconda che il soggetto sia qualificabile (in base alle definizioni di cui al punto 1 del Provvedimento) come holding, sub-holding o impresa controllata.
Specifiche disposizioni sono state previste in riferimento alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti (punto 6) e, indipendentemente dalla tipologia di soggetto, alle piccole e medie imprese (punto 7), allo scopo, in tale ultimo caso, di pervenire ad una semplificazione dell’onere documentale in argomento. Tali previsioni trovano approfondimento nel prosieguo.
La Cir. 58/E del 2010 sottolinea come le definizioni fornite dal punto 1 del Provvedimento non hanno la finalità di tipizzare nuove categorie di soggetti o di introdurre una nuova classificazione giuridica rispetto a quelle già previste dall’ordinamento. In altri termini, tali definizioni non hanno effetto sui presupposti soggettivi di applicabilità dell’art. 110, comma 7 del TUIR, che, in quanto tali, restano impregiudicati. Si tratta, pertanto, di definizioni convenzionali finalizzate alla corretta applicazione dei contenuti del Provvedimento.
Documentazione idonea per le Holding e le Sub-holding
Per quanto concerne le cc.dd. “holding” e “sub-holding” , il punto 3 del Provvedimento dispone che la documentazione idonea deve essere costituita sia dal Masterfile sia dalla Documentazione Nazionale.
Art. 1 del Provvedimento
Per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato”.
Per “società sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato”.
Mentre per le holding si applica in misura piena il paradigma previsto dal punto 2 del Provvedimento - secondo il quale la documentazione idonea è costituita appunto dal Masterfile e dalla Documentazione Nazionale - alle società sub-holding è consentito includere nel Masterfile informazioni riguardanti il solo sotto-gruppo al cui vertice è posta la sub-holding. Tale facoltà è infatti coerente con uno dei principi alla base del sistema, che implica il diverso atteggiarsi dell’onere in ragione del grado di informazioni e documentazione ragionevolmente in possesso del soggetto (di cui si è detto al precedente par. 3). La sub-holding residente potrà in ogni caso presentare, in luogo del Masterfile richiesto dal Provvedimento, il Masterfile relativo all’intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione Europea. Tale ulteriore facoltà, tuttavia, è subordinata a due condizioni: la prima è che lo stesso sia conforme ai contenuti del Codice di Condotta; la seconda prevede che qualora il Masterfile dell’intero gruppo predisposto dalla holding rechi minori informazioni relative al sottogruppo rispetto a quelle previste dal Provvedimento, la sub-holding ne integri i contenuti. Tale ultima considerazione è giustificata dalla considerazione che gli Stati Membri hanno facoltà di implementare il Codice di Condotta, adattandone i contenuti al contesto interno.
La Cir. 58/E del 2010 precisa che la facoltà prevista per la sub-holding di presentare il Masterfile dell’intero gruppo vale sia nel caso in cui la holding che ha redatto il Masterfile sia un soggetto residente in Italia, sia nel caso in cui si tratti di soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione Europea. In ogni caso, il Masterfile predisposto dalla holding non residente, ovvero le eventuali integrazioni a cura della sub-holding, potranno essere formulati in lingua inglese (v. anche punto 8.1 del Provvedimento). In coerenza con quanto previsto dal punto 8.1 del Provvedimento, l’utilizzo della lingua inglese non è consentito nel caso in cui il Masterfile utilizzato dalla sub-holding sia stato predisposto da una holding residente in Italia.
In ultimo la Circ. 58/E del 2010 ritiene che, per ragioni di coerenza con gli standard internazionali, potrà essere consentita, alle medesime condizioni sopra declinate, la presentazione del Masterfile predisposto da una holding non residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, a condizione che tra detto Stato e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni ovvero un accordo per lo scambio di informazioni.
Documentazione idonea per le imprese controllate
Il punto 5 del Provvedimento statuisce che le imprese controllate4 residenti appartenenti ad un gruppo multinazionale dovranno predisporre solo la Documentazione Nazionale.
Art. 1 del Provvedimento
Per impresa controllata, il Provvedimento intende “una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;
- non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato”.
Anche in tal caso trovano piena conferma i principi sottesi alla diversificazione dell’onere: in analogia a quanto previsto per le sub-holding - per le quali la predisposizione del Masterfile può riguardare il solo sottogruppo al cui vertice è posta la sub-holding - tale principio non può che esplicitarsi, nella specie, nel senso di richiedere all’impresa controllata unicamente informazioni cui la stessa può legittimamente accedere.
Documentazione idonea per le stabili organizzazioni
Per quanto riguarda invece le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, il Provvedimento pone a carico delle stesse un regime di oneri che varia a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte si qualifichi come holding, sub-holding o impresa controllata. Anche in tal caso, vige il più volte richiamato principio, in base al quale l’onere documentale trova specifica diversificazione in ragione del grado di accessibilità alle informazioni da parte dell’impresa. Pertanto, se la società non residente di cui la stabile organizzazione è parte si qualifica come una holding o una sub-holding, la stabile organizzazione in Italia, al fine di adempiere al proprio onere documentale, dovrà presentare sia il Masterfile sia la Documentazione Nazionale, con la precisazione che, in presenza di sub-holding non residente, la stabile organizzazione potrà presentare, in luogo del Masterfile relativo al sottogruppo al cui vertice è posta la sub-holding non residente, il Masterfile predisposto da altro soggetto secondo i termini e le condizioni di cui al punto 4 del Provvedimento. Infine, se la società non residente di cui la stabile organizzazione è parte si qualifica come società controllata, la stabile organizzazione dovrà presentare solo la Documentazione Nazionale.
Conclusioni in merito alla diversificazione dell’onere documentale
In sintesi, la documentazione idonea, a seconda della diversa tipologia di contribuente interessato, può essere riepilogata nella tabella che segue:
La disciplina specifica per le piccole e medie imprese
In considerazione del fatto che le informazioni contenute nella documentazione devono essere aggiornate anno per anno, ivi inclusa l’analisi di comparabilità e le relative procedure di selezione di operazioni comparabili, il Provvedimento prevede per le piccole e medie imprese la facoltà di non aggiornare, in esito alle risultanze dell’analisi di comparabilità, i dati derivanti dalla procedura di selezione dei comparabili indicati al sottoparagrafo 5.1.3 (“Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni”) della Documentazione Nazionale in merito ai due periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione. Trattasi, in particolare, delle modalità di ricerca e selezione di transazioni comparabili basate su informazioni pubblicamente disponibili, quali ad es. bilanci d’esercizio depositati presso Camere di Commercio ovvero desumibili da banche dati commerciali. Tale semplificazione, tuttavia, è subordinata alla condizione che i fattori di cui alle lettere da a) ad e) del sottoparagrafo 5.1.2 della Documentazione Nazionale non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta. I fattori richiamati che, ai fini della semplificazione, non devono aver subito modificazioni significative, sono quelli che rilevano ai fini dell’analisi di comparabilità ossia le caratteristiche dei beni e servizi, le funzioni svolte, i rischi assunti, i beni strumentali utilizzati, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie di impresa. La circ. 58/E del 2010 raccomanda di prestare particolare cautela in ordine all’appuramento o meno di variazioni nei cosiddetti cinque fattori della comparabilità sopra indicati, in quanto ordinariamente, nel corso dell’attività di un’impresa, è assolutamente normale che tali fattori subiscano variazioni più o meno rilevanti. “Pertanto l’utilizzo del termine “modificazioni significative” va inteso nel senso di variazioni di tale rilevanza che, in un contesto di soggetti indipendenti, le stesse sarebbero suscettibili di incidere in modo importante sulle condizioni delle operazioni tra gli stessi intervenute e, quindi, sulla valorizzazione delle stesse”.
Il verificarsi delle condizioni previste dal Provvedimento al fine di poter godere della semplificazione di cui si è detto non esime le piccole e medie imprese dal fornire informazioni, per ogni singolo anno, sulla società, sui settori di attività, sulla struttura e le strategie, sulle operazioni infragruppo oltre che sui fattori di cui alle lettere da a) ad e) del sottoparagrafo 5.1.2 della Documentazione Nazionale in precedenza richiamati. Dovranno aggiornarsi, altresì, i dati di cui al capitolo 9 in merito ai rapporti con le Amministrazioni fiscali dei Paesi UE concernenti APA e ruling in materia di prezzi di trasferimento.
Si segnala che, con tale intervento, il Provvedimento ha di fatto recepito le indicazioni delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento e del Codice di Condotta UE, in merito alla previsione di misure atte a ridurre il peso degli oneri documentali per le piccole e medie imprese.
La forma, l’estensione e le condizioni di efficacia della documentazione idonea
Aspetti formali: la lingua e il formato della documentazione. Il punto 8.1 del Provvedimento, prevede che il Masterfile e la Documentazione Nazionale debbano essere redatti in lingua italiana, salvi i casi in cui si rendano applicabili le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. E’ comunque possibile presentare eventuali allegati in lingua inglese.
Il Masterfile potrà invece essere presentato in lingua inglese nell’ipotesi in cui una sub-holding si avvalga della facoltà, prevista al punto 4 del Provvedimento ed esplicitata al punto 6.1, di esibire, in luogo di un proprio Masterfile, quello predisposto da un soggetto non residente.
La circ. 58/E del 2010 precisa che gli allegati alla Documentazione Nazionale e gli eventuali allegati al Masterfile, qualora consistenti in documenti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, dovranno essere tradotti in una delle suddette due lingue, e consegnati in copia dell’originale.
Sia il Masterfile sia la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e firmati in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma elettronica. Nel caso di Masterfile prodotto da una sub-holding appartenente ad un gruppo multinazionale che si sia avvalsa della citata facoltà di cui al punto 4 del Provvedimento di presentare il Masterfile predisposto da un soggetto non residente, la firma del rappresentante legale del contribuente onerato fa fede della conformità della copia esibita all’originale del documento.
Il Provvedimento stabilisce, altresì, che la documentazione deve essere presentata in formato elettronico, intendendosi per tale un documento digitalizzato in formato non modificabile. Qualora la documentazione venga esibita in formato cartaceo, tale circostanza non pregiudica l’applicazione del regime di disapplicazione delle sanzioni, a condizione che la stessa sia resa disponibile entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all’attività di controllo così come previsto dal punto 8.1. del Provvedimento.
Termini di consegna. La disapplicazione del regime sanzionatorio si basa sull’apprezzamento del comportamento in buona fede e collaborativo del contribuente, in ragione di uno sforzo finalizzato alla predisposizione di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Questa impostazione è volta ad apprezzare una spontanea predisposizione di documentazione, in quanto non sollecitata da accessi, ispezioni, verifiche o da altre attività istruttorie. La circ. 58/E del 2010 rileva che la consegna della documentazione, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, può comportare, per i contribuenti, un normale lasso di tempo necessario per la collazione della stessa (si pensi, ad esempio, al caso della richiesta del Masterfile relativo all’intero gruppo da parte della sub-holding italiana nei casi previsti dall’art. 4 del Provvedimento). Tale essendo l’ottica di riferimento, in assenza di consegna immediata, il contribuente, ai sensi del punto 8.2. del Provvedimento ha la facoltà di consegnare la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dal beneficio previsto dal comma 2-ter dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Qualora nel corso della verifica o di altra attività istruttoria dovesse rendersi necessario disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata dal contribuente all’Amministrazione finanziaria, le stesse dovranno essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta. Compatibilmente con i tempi del controllo, potrà essere previsto un termine più ampio in funzione della complessità delle operazioni oggetto di analisi. Le richieste supplementari di cui al punto 8.2 del Provvedimento devono avere a oggetto informazioni costituenti parte del contenuto ordinario della documentazione come declinato dal Provvedimento nei punti 2.1 e 2.2. Qualora, invece, l’integrazione richiesta avesse ad oggetto informazioni supplementari che esulano dal contenuto ordinario della documentazione previsto dal Provvedimento, l’eventuale mancata consegna non costituisce presupposto per il venir meno del regime di disapplicazione delle sanzioni.
Estensione delle condizioni di efficacia della documentazione idonea. Il punto 8.3 del Provvedimento dispone che la documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente che ricadono nell’ambito di applicazione del comma 7 dell’art. 110 del Tuir e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi di imposta soggetti ad accertamento secondo i termini previsti dall’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973.
Si rileva, pertanto, che la documentazione deve riguardare uno specifico periodo d’imposta e, coerentemente con il principio di unitarietà previsto dall’art. 76 del Tuir, rimane impregiudicata la facoltà del contribuente di adottare o meno il regime di oneri documentali per altri periodi.
In ultimo la circ. 58/E del 2010 osserva che il riferimento del punto 8.3 del Provvedimento al fatto che l’amministrazione non utilizza le informazioni per scopi diversi da quelli istituzionali mira a circoscrivere l’utilizzo delle stesse e, in particolare quelle relative a processi produttivi, brevetti, formule o segreti industriali, alle attività istruttorie riconducibili al controllo in essere.
La valutazione della idoneità della documentazione
Il Provvedimento dispone al punto 8.3 che l’Amministrazione finanziaria non è vincolata alla disapplicazione della sanzione in materia di dichiarazione infedele, qualora la documentazione esibita nel corso dell’attività di controllo, pur essendo coerente con la struttura formale di cui ai punti 2.1 e 2.2 dello stesso, non presenta contenuti completi o conformi alle disposizioni ivi contenute.
Tale considerazione è legata al fatto che il concetto di “idoneità” introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità, appunto, della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. In tal senso, al fine di fornire un paradigma di riferimento e minimizzare, per quanto possibile, profili di discrezionalità in merito al giudizio di idoneità, la norma e il Provvedimento operano un esplicito riferimento ai principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida OCSE.
Il Provvedimento, come già evidenziato, chiarisce in specie che la documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contenga informazioni complete e conformi a quanto previsto nel Provvedimento medesimo, così come quando le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero.
La cir. 58/E del 2010 segnala che, nel caso in cui, pur in presenza della comunicazione di cui al punto 9 del Provvedimento, non venga riscontrato in sede di controllo il possesso della documentazione (vale a dire è stata effettuata la comunicazione ma non vi è il possesso della documentazione ) e, più in generale, ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente, tali circostanze andranno tenute in debito conto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla rettifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo (mediante un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento).
La circolare precisa inoltre che le omissioni o le inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi, non pregiudicano l’applicazione del regime premiante di cui al comma 2-ter dell’art. 1 del Dlgs n. 471 del 1997. La stessa precisazione vale con riferimento al caso della omissione degli allegati citati al punto 2.2 del Provvedimento.
Ovviamente, gli organi di controllo potranno richiedere la documentazione mancante o integrativa nel corso del controllo applicando i termini previsti al punto 8.2 del Provvedimento (sette giorni dalla richiesta o un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi).
Nelle menzionate omissioni parziali può ritenersi compresa anche l’omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni oggetto di documentazione, qualificabili come tali proprio in quanto non sono in grado di pregiudicare l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa.
La valutazione dell’idoneità della documentazione deve essere effettuata dai verificatori se la stessa viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
La cir. 58/E del 2010 precisare che, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia aderito al regime di oneri documentali previsto dalla normativa in commento, è da ritenere esclusa la possibilità di adesione al verbale di constatazione che contenga rilievi sui prezzi di trasferimento ai sensi dell’art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,. Ciò in quanto, “in tale ipotesi, il verbale non consente di individuare le sanzioni minime sulle quali opererebbe la riduzione prevista dalla norma citata, dato che l’applicabilità di quelle connesse ai rilievi sui prezzi di trasferimento è rimessa alla successiva valutazione dell’Ufficio accertatore”.
La circolare prevede inoltre che
- Qualora emergano, in sede di controllo, situazioni di particolare complessità nella valutazione di idoneità della documentazione presentata dal contribuente, l’Ufficio procedente deve immediatamente interessare la competente Direzione Regionale, per ricevere le direttive del caso.
- Qualora l’Ufficio pervenga ad una prognosi di inidoneità motivatamente non condivisa dal contribuente, la questione va sempre tempestivamente rimessa, per la relativa decisione, alla Direzione Regionale. Qualora la rettifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo sia di importo superiore a dieci milioni di euro, la questione deve essere tempestivamente rimessa alla Direzione Centrale Accertamento, per il tramite della Direzione Regionale. .
Nelle suddette situazioni, l’Ufficio inoltra un’apposita relazione sulla valutazione effettuata, evidenziando eventuali situazioni di complessità nonché le deduzioni del contribuente, allegando e commentando eventuali memorie dallo stesso presentate in merito alla pretesa idoneità della documentazione consegnata, oltre che copia dei verbali dai quali si rilevi il contraddittorio con la parte avente ad oggetto gli elementi documentali forniti. Per le ipotesi rimesse alla decisione della Direzione Centrale Accertamento, la Direzione Regionale inoltra, a propria volta, un’apposita relazione che riassuma gli elementi forniti dall’Ufficio ed esprima la propria posizione.