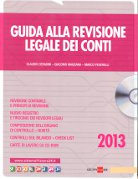RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A RICAVI NETTI E COSTO DEL VENDUTO
ARTICOLO - Pubblicato il: 17 marzo 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
In economia aziendale il conto economico, secondo l'ordinamento giuridico, è il documento del bilancio d'esercizio che, contrapponendo i costi e i ricavi di cometenza del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato.
Lo schema è il seguente:
CONTO ECONOMICO A RICAVI NETTI E COSTO DEL VENDUTO
+ Ricavi netti
- Costo del Venduto
+ rimanenze iniziali (indipendentemente dalla tipologia)
+ costi della produzione per materie prime
+ costi per servizi acquisiti per l’esercizio dell’attività produttiva
+ costi per il godimento di beni di terzi impiegati nell’attività produttiva
+ costi del personale coinvolto nell’attività produttiva
+ ammortamenti e svalutazioni di beni legati all’attività produttiva
+ accantonamenti per rischi e altri accantonamenti legati all’attività produttiva
+ oneri diversi di gestione legati all’attività produttiva
- variazioni dei lavori in corso
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- rimanenze finali (indipendentemente dalla tipologia)
= Risultato Industriale
- costi generali e amministrativi
- costi commerciali e distributivi
= Reddito Operativo
+o - risultato della gestione finanziaria
+o - risultato della gestione accessoria
+o - risultato della gestione straordinaria
= Reddito Ante Imposte
- Gestione fiscale
= Reddito Netto
Grazie a tale schema è possibile evidenziare in maniera particolareggiata tutte le aree gestionali, vale a dire:
- gestione operativa
Comprende tutte i costi e ricavi inerenti i processi di acquisizione, trasformazione, vendita dei prodotti e/o servizi tipici dell’attività aziendale;
- gestione accessoria
Ha per oggetto tutte quelle attività svolte con continuità ma estranee alla gestione tipica dell’impresa (è tipico il caso della riscossione di affitti attivi su immobili non strumentali all’esercizio di impresa, dove il concetto di strumentalità deve essere inteso non in senso fiscale, quanto in senso operativo, e quindi in questo caso fare riferimento al fatto che l’attività operativa può essere svolta anche a prescindere dalla disponibilità di tali immobili; un altro tipico esempio è costituito dalla gestione degli investimenti finanziari, quando questi non appartengono all’ambito dell’attività operativa dell’impresa;
- gestione finanziaria
E’ rappresentata dai costi e dai ricavi collegati alla struttura dei finanziamenti e degli investimenti aziendali, ossia dagli oneri e dai proventi finanziari (tipicamente interessi passivi su conti correnti o su mutui in essere, ovvero interessi attivi sulla liquidità impiegata);
- gestione straordinaria
Ha per oggetto quelle operazioni che determinano componenti di costo o di ricavo la cui manifestazione non ha carattere di prevedibilità e di ricorrenza, in genere quindi non attribuibili alle combinazioni produttive dell’esercizio (ad esempio plus e minusvalenze o ancora sopravvenienze attive o passive);
- la gestione fiscale
Da intendersi come l’insieme del carico fiscale relativo alle sole imposte sul reddito, trovando le altre posizioni nei confronti dell’erario naturale allocazione tra gli oneri di carattere più specificatamente operativo.
Tale riclassificazione, interessa in modo particolare le imprese che svolgono un’attività produttiva, di trasformazione industriale, ed è invece di scarso imparo per aziende di servizi o commerciali. Attraverso la presente riclassificazione si vuole cercare di capire, infatti, l’incidenza del costo della produzione venduta, nonché della gestione commerciale e amministrativa.
Le singole categorie di voci sono composte, ricordando lo schema di cui all’art. 2425 c.c., nel modo seguente:
Ricavi netti
Comprendono ricavi delle vendite e delle prestazioni, espressi al netto di eventuali elementi correttivi quali abbuoni, sconti e ribassi;
Costo del venduto
Il costo del venduto esprime il costo dei fattori produttivi utilizzati per ottenere il prodotto posto sul mercato ed è costituito dalla somma algebrica delle seguenti voci:
+ rimanenze iniziali (indipendentemente dalla tipologia)
+ costi della produzione per materie prime
+ costi per servizi acquisiti per l’esercizio dell’attività produttiva
+ costi per il godimento di beni di terzi impiegati nell’attività produttiva
+ costi del personale coinvolto nell’attività produttiva
+ ammortamenti e svalutazioni di beni legati all’attività produttiva
+ accantonamenti per rischi e altri accantonamenti legati all’attività produttiva
+ oneri diversi di gestione legati all’attività produttiva
- variazioni dei lavori in corso
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- rimanenze finali (indipendentemente dalla tipologia)
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono una tipica voce il cui significato contabile e economico è indiscutibile, ma la cui influenza in sede di analisi potrebbe essere eccessiva, poiché si rischia di non riuscire a neutralizzare l’effetto dei costi operativi sostenuti in modo ed esauriente. Si noti che un’eventuale svalutazione/rivalutazione di partecipazioni considerata operativa e finalizzata all’esercizio dell’attività produttiva dovrebbe essere inserita tra gli elementi di composizione del costo del venduto, così come un ricavo generato da una partecipazione operativa potrebbe essere assimilato ai ricavi di vendita tradizionali (in realtà vi sono voci di conto economico la cui imputazione è assai poco chiaramente definibile con certezza);
RISULTATO INDUSTRIALE
Di notevole importanza per l’analisi, esprime la capacità o l’incapacità dell’impresa, relativamente all’area gestionale di pertinenza, di svolgere in modo conveniente l’attività di trasformazione, e quindi di generare risorse sufficienti a sostenere gli oneri indotti dalla gestione amministrativa e commerciale, nonché a remunerare i prestatori e i sottoscrittori di capitale (oltre che ovviamente a far fronte alle gestioni accessoria, straordinaria e fiscale).
Un risultato industriale negativo esprime la probabile incapacità dell’impresa di stare sul mercato a condizioni vantaggiose, ed è tipico di situazioni in cui ad esempio al calo del fatturato non si è riusciti a porre rimedio attraverso un’adeguata e corrispondente contrazione degli oneri di trasformazione. Ciò è tutt’altro che improbabile, perché sono proprio gli oneri di produzione quelli più frequentemente caratterizzati da condizioni di rigidità (i c.d. costi dello stabilimento) che se in periodi di congiuntura positiva consentono all’impresa di generare margini via via crescenti (perché la loro crescita è in genere meno che proporzionale), altrettanto in periodi di tensione sul fatturato ribadiscono la loro sostanziale staticità provocando appunto una forte contrazione del risultato industriale. L’ipotesi di un risultato industriale minore di zero è quindi al contempo monito e stimolo per il management dell’impresa, costretto a rivedere analiticamente le procedure di acquisto/trasformazione/vendita che hanno condotto ad un simile risultato;
Costi generali e amministrativi
Comprendono costi per servizi, per il godimento di beni di terzi, del personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti, oneri diversi di gestione tutti imputabili all’area amministrativa e delle spese generali (sono genericamente definibili come i costi “d’ufficio”). L’imputazione corretta di tali voci implica ovviamente la disponibilità degli opportuni riferimenti contabili;
Costi commerciali e distributivi
Comprendono costi per servizi, per il godimento di beni di terzi, del personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti, oneri diversi di gestione tutti imputabili all’area commerciale e distributiva (sono genericamente definibili come i costi di vendita, e anche in questo caso è necessaria una loro possibile identificazione “contabile”);
REDDITO OPERATIVO
E’ sicuramente l’indicatore che meglio sintetizza la capacità di svolgere in modo conveniente la propria attività tipica; valori di RO>O esprimono la superiorità dei ricavi operativi rispetto all’insieme dei costi coinvolti nell’attività tradizionale, e quindi prescindendo dall’esercizio di eventuali attività accessorie, dal conseguimento di oneri/proventi straordinari, dalla destinazione di impiego ovvero dalla raccolta di capitale finanziario (sintetizzato nella gestione finanziaria) e dal peso delle imposte sul reddito. Ovviamente non significa che un RO>O sia sufficiente a remunerare in modo adeguato il capitale di rischio attraverso il reddito netto; è piuttosto vero il contrario, e quindi che un RO<O deve rappresentare un importante elemento di valutazione delle scelte aziendali. Se a tale risultato hanno contribuito elementi di forte contingenza (ad es. repentine fluttuazioni nei prezzi di acquisto ovvero di vendita) si può ragionevolmente pensare che la situazione possa rapidamente cambiare; livelli di RO non casualmente negativi devono invece portare a più serie e definite riflessioni sulla compatibilità dell’area di attività esercitata, e se del caso anche ad una riconversione da parte dell’impresa.
Il reddito operativo rappresenta un elemento di grande rilievo nel confronto tra aziende operanti negli stessi comparti: valori di RO più elevati (in percentuale sul fatturato, o sul capitale investito) evidenziano la migliore capacità competitiva dell’ impresa, che potrebbe peraltro essere vanificata per la remunerazione del capitale finanziano. Redditi operativi molto elevati sono in genere caratteristici di alcuni tipi di aziende, tra cui quelle industriali con ingenti capitali investiti. D’altro canto esistono aziende che possono permettersi un reddito operativo negativo in quanto la loro attività le porta a conseguire redditi attraverso la gestione finanziaria (ad esempio le imprese della grande distribuzione).
In condizioni di acquisto e di vendita normali il reddito operativo esprime il reddito che l’impresa produce dalla sua attività caratteristica a prescindere da come essa sia finanziata.
Quando, peraltro, l’impresa concede più credito del normale o utilizza più debiti commerciali rispetto al normale il reddito operativo risente molto delle componenti finanziarie. In particolare si possono presentare due situazioni:
- il maggior credito commerciale concesso o goduto genera un incremento dei ricavi o dei costi (per gli oneri finanziari impliciti contenuti) che si riflette sul reddito operativo stesso; in altri termini, l’impresa che vende con forti dilazioni di pagamento, e che riesce a farsi riconoscere questa posizione dal cliente, registrerà ricavi superiori al normale, e di conseguenza avrà un maggiore livello di reddito operativo;
- il maggior credito commerciale concesso o goduto non genera incrementi di ricavi o di costi (per il potere contrattuale dei clienti o dell’impresa nei confronti dei suoi fornitori), per cui a parità di reddito operativo si modificherà il reddito netto a causa rispettivamente di maggiori o minori oneri finanziari (in pratica se l’impresa non riesce a modificare il valore della vendita con pagamento dilazionato, si troverà a dover fare fronte ad un maggiore livello di oneri finanziari).
Ciò porta di fatto ad una commistione tra le gestioni operativa e finanziaria, di cui si è già detto parlando delle riclassificazioni dello stato patrimoniale, che spesso genera qualche problema interpretativo in fase di analisi.
Risultato della gestione finanziaria
Tale valore accoglie con segno positivo o negativo a seconda dei casi i proventi e gli oneri finanziari.
Si tratta di un risultato molto importante, che esprime la capacità dell’impresa di fare fronte alle scelte di raccolta ed eventualmente di impiego delle risorse finanziarie in modo conveniente, vale a dire privilegiando quelle forme la cui onerosità ovvero il tasso di rendimento si presenta come più conveniente. La gestione finanziaria è spesso fonte di distorsioni nell’analisi di bilancio, per il verificarsi di alcuni fenomeni; sarebbe infatti opportuno distinguere:
- gli oneri finanziari derivanti dalle scelte di statura finanziaria, e quindi dalla maggiore o minore incidenza dell’indebitamento (in genere, mutui o finanziamenti a fronte di investimenti in immobilizzazioni);
- gli oneri finanziari derivanti dal fabbisogno generato dalIa normale e ricorrente attività di acquisto-trasformazione-vendita: questi sono giustamente censiti come oneri finanziari; in sede di analisi però, ed eventualmente di comparazione con i risultati di precedenti periodi, si dovrebbe ricordare la loro natura operativa, e quindi la loro diretta influenza sulla determinazione del reddito operativo. Ad esempio, accade che alcune operazioni di acquisto/vendita vengano concordate a prezzi diversi da quelli correnti per compensare le maggiori dilazioni. Nel caso di una cessione di servizi con forte dilazione di pagamento, l’azienda venditrice contabilizzerà minori redditi finanziari (o maggiori oneri, se già comunque indebitata) rispetto a quelli che avrebbe registrato se l’operazione fosse stata regolata per contanti, l’azienda acquirente invece contabilizzerà maggiori oneri finanziari (o minori oneri, se già comunque indebitata).
Un’altra situazione che genera difficoltà interpretative riguarda la presenza di canoni di leasing: tali canoni infatti incorporano tanto la componente di ammortamento che quella di onere finanziario, ma vengono iscritti per intero tra i costi operativi. E evidente che il confronto tra due aziende, delle quali solo una facesse ricorso ai contratti di leasing, sarebbe in parte fuorviante se non tenesse in conto anche questo fenomeno (al riguardo una possibile soluzione è rappresentata dalla scissione del canone nelle due componenti di quota interessi e quota capitale, con quest’ultima assimilata a costo di natura operativa; in pratica parte del canone di leasing verrebbe estrapolato dalla voce spese per il godimento di beni di terzi e diversamente allocato).
Un altro caso di difficile interpretazione del valore degli oneri finanziari riguarda le differenze di cambio; sulle monete corrono infatti tassi di interesse sostanzialmente diversi, a fronte dei quali vi sono anche prospettive di variazione del rapporto di cambio. Così, se un’azienda si finanziasse contraendo un debito denominato in una valuta su cui gravano interessi contenuti, dovrebbe di norma alla scadenza registrare la presumibile perdita su cambi subita alla stregua di onere finanziano.
Risultato della gestione accessoria
Accoglie la voce relativa ad alti ricavi e proventi, con esclusione dei contributi in conto capitale (che, se presenti con carattere di straordinarietà, come presumibile, a tale gestione andrebbero ricondotti) ed eventualmente i costi a tali ricavi collegati, che andranno estrapolati tra le categorie di costi operativi di cui sopra; inoltre, a tale gestione vengono imputate le risultanze economiche (rivalutazioni e svalutazioni comprese) di quegli impieghi la cui natura è definibile come non collegata all’attività operativa dell’impresa.
La gestione accessoria dovrebbe accogliere quindi componenti di scarso peso relativo sulle altre voci di conto economico: qualora si riscontrasse il contrario, sarebbe opportuno procedere ad un’indagine riguardo alla capacità di affrontare ambiti operativi ormai anche molto diversi da quelli tradizionali. Ciò quindi a ricordare che un peso elevato della gestione accessoria e dei suoi componenti non deve a priori essere rigettato, ma certo implica la capacità di svolgere operazioni diverse a quelle classiche di acquisto-trasformazione e vendita, e forse denota che con il passare del tempo si è realizzata una sorta di inversione tra quella che erano le attività operativa e accessoria, con una prevalenza di quest’ultima, la quale ragionevolmente deve allora considerarsi la “vera” attività operativa (è il caso delle imprese per le quali nel tempo assume rilievo l’investimento immobiliare, e che si trovano appunto a svolgere tale attività con preminenza, o di quelle che sfruttando ad esempio condizioni vantaggiose negli elementi di incasso e pagamento realizzano la possibilità di destinare ingenti somme a investimenti di vario tipo, non collegati con l’attività tradizionale).
Risultato della gestione straordinaria
Le voci di cui ai punti 20 e 21 dello schema di conto economico, e quindi proventi e oneri straordinari. Benché tale aggettivo lasci presumere l’assoluta eccezionalità di tali poste, è raro trovare un bilancio che ne sia privo.
Volendo esaminare in maniera corretta la natura delle voci che le compongono, si potrebbe sostenere che plusvalenze e minusvalenze di fatto esprimono la
scorrettezza delle politiche di ammortamento adottate negli anni precedenti, soprattutto se la loro entità è elevata e la loro presenza sistematica, e quindi si dovrebbe giungere ad un “ripensamento” delle politiche di ammortamento (sottinteso, dal punto di vista civilistico).
Quanto alle sopravvenienze attive o passive, esse sono spesso collegate al venire meno di posizioni rispettivamente debitorie ovvero creditorie, e forse sarebbe più opportuno ricondurne la destinazione tra le componenti di carattere operativo, anche se si tratta di una prassi assolutamente poco utilizzata. Un peso elevato delle componenti straordinarie deve comunque portare ad una riflessione da un lato in merito alle politiche contabili adottate nel corso degli anno, e dall’altro alla caratteristica di scarsa ripetitività dell’attività tipica d’azienda.
REDDITO ANTE IMPOSTE
Viene calcolato col solo fine di evidenziare in modo separato l’incidenza della variabile fiscale; diventa un riferimento importante, qualora confrontato con il reddito operativo, per valutare il peso delle gestioni finanziarie, accessoria e straordinaria.
Imposte sul reddito
Tale voce accoglie le sole imposte sul reddito, la cui procedura di calcolo, implica il passaggio attraverso una ricostruzione del reddito assoggettato a tassazione. Tale voce deve inoltre contenere l’imposizione differita (attiva o passiva).
REDDITO NETTO
Benché attraverso la riclassificazione sia possibile evidenziare anche e altri importanti indicatori di redditività, rappresenta sempre il riferimento imprescindibile di un’analisi di bilancio a qualsiasi livello condotta. E’ nota al riguardo l’influenza delle politiche seguite nella stesura, e dei margini di discrezionalità che possono portare a valori anche sostanzialmente diversi per la stessa azienda a seconda dei principi che si intende seguire. Ciò nonostante il reddito netto è l’indicatore più immediatamente “osservato” dall’analista, che ricondurrà a questa voce anche eventuali elementi di costo imputati con finalità fiscali (si pensi a compensi per gli amministratori-proprietari in misura eccedente rispetto al loro contributo lavorativo) di tipo “accessorio”.